Un numero pubblicato dall’Istat entra direttamente nel portafoglio di chi sta progettando la pensione: il coefficiente che rivaluta i montanti contributivi è stato aggiornato e porta con sé una crescita visibile degli assegni per chi andrà in pensione nel 2026. La notizia non è solo statistica: si traduce in importi concreti nelle buste degli italiani che maturano il diritto nel corso dell’anno. Lo raccolgono i calcoli tecnici, lo confermano i numeri e, per molti, sarà la differenza tra una rata più alta o più bassa.
Indice
Il nuovo tasso e cosa comporta
L’Istat ha calcolato un tasso medio annuo composto della variazione del Pil nominale pari a 0,040445 per il quinquennio di riferimento. Da questo valore deriva un coefficiente di rivalutazione del montante pari a 1,040445, cioè una crescita del 4,04%. Si tratta del tasso più elevato dagli anni Duemila ed è il risultato di una combinazione tra rimbalzo economico post-pandemia e l’aumento generale dei prezzi. Questo valore significa che il saldo virtuale dei contributi versati cresce più rapidamente rispetto agli anni passati, con un impatto diretto sui montanti accumulati.
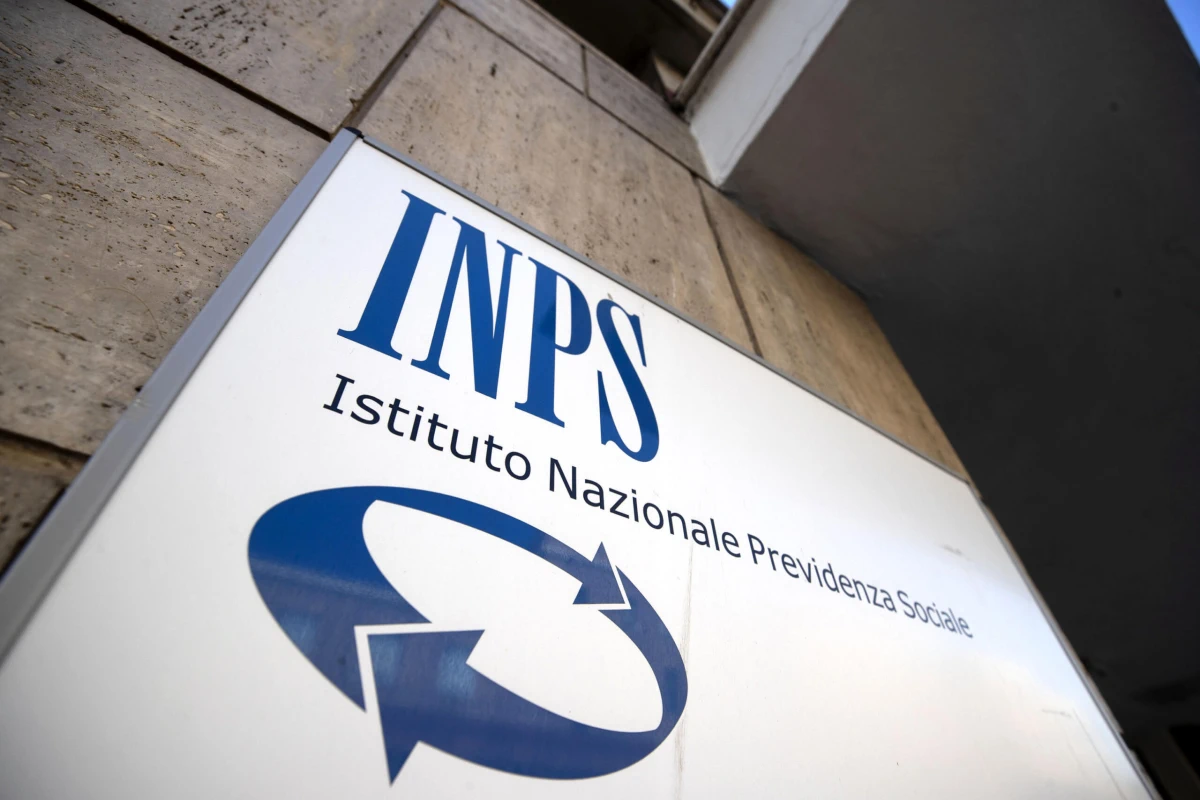
Per mettere in prospettiva: una quota di 100.000 euro nel montante diventerebbe circa 104.044 euro dal 1° gennaio 2026 grazie alla rivalutazione. Il trend è in crescita da qualche anno: dopo il 2,3% e il 3,6% dei due anni precedenti, si registra ora un ulteriore rialzo. Un dettaglio che molti sottovalutano è che dal 2015 esiste una norma che impedisce la riduzione del montante anche in presenza di Pil negativo: è una soglia di protezione che tutela il valore nominale dei versamenti.
Il tasso del 4,04% rispecchia una crescita cumulata del Pil nominale del 21,93% nel periodo considerato. Per il sistema previdenziale italiano questo si traduce in maggiori risorse per i conti individuali e in una conferma del legame tra economia nazionale e trattamento pensionistico.
Chi beneficia davvero e come si calcola l’aumento
La rivalutazione del 4,04% si applica solo ai contributi versati fino al 31 dicembre 2024. Di conseguenza, i pensionandi che presenteranno domanda e usciranno dal lavoro tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 potranno vedere assegni più alti rispetto a chi smette prima. Chi invece lascia il lavoro entro la fine del 2025 vedrà applicato il coefficiente precedente, con una differenza che su montanti elevati può tradursi in alcune centinaia di euro all’anno. Un aspetto che sfugge a chi vive in città è che l’effetto è proporzionale al montante: più contributi si sono versati, maggiore è il vantaggio in valore assoluto.
Un esempio pratico chiarisce il meccanismo: un montante di 300.000 euro rivalutato del 4,04% porta a circa 312.120 euro. Applicando un coefficiente di trasformazione pari al 5,608% (indicativo per l’età di 67 anni), il trattamento annuo calcolato risulterebbe intorno a 17.504 euro, ovvero una pensione mensile lorda di circa 1.346 euro. È il montante, più che la singola percentuale, a determinare la misura finale dell’assegno.
La rivalutazione interessa tutti gli iscritti alle gestioni INPS — dipendenti, autonomi e professionisti — anche se alcune Casse private possono adottare regole di calcolo lievemente diverse. Per questo motivo, chi ha carriere stabili e montanti consistenti ottiene il beneficio più evidente; al contrario, chi ha periodi di contribuzione sparsi riceverà un aumento proporzionalmente più contenuto.
Chi resta escluso e quali scelte valutare
Non tutti godranno dell’aumento: restano esclusi chi andrà in pensione entro il 31 dicembre 2025, i già pensionati che percepiscono una rivalutazione legata soltanto all’indice dei prezzi e chi riceve prestazioni assistenziali come assegni sociali o pensioni integrate al minimo, perché tali importi non dipendono dai contributi versati. Va inoltre ricordato che la rivalutazione non riguarda i contributi versati nell’anno del pensionamento né quelli dell’anno precedente, dunque i versamenti del 2025 non entrano nel calcolo per chi esce nel 2026. Questo è un dettaglio tecnico che può influire sulle decisioni di chi è vicino all’età utile per la pensione.
Il montante contributivo, ricordiamolo, è la somma dei versamenti rivalutati annualmente secondo la dinamica del Pil: quando si raggiunge l’età per andare in pensione, quel montante viene trasformato in rendita tramite il coefficiente legato all’età di uscita. Il sistema adottato con la riforma Dini del 1995 premia la continuità contributiva e la durata della carriera. Per questo motivo, posticipare l’uscita dal lavoro può comportare un coefficiente più favorevole e dunque un assegno maggiore, ma il beneficio è significativo soprattutto per chi ha una carriera lineare e montanti elevati.
Per molti italiani si tratta di una verifica pratica della tenuta del sistema previdenziale: l’aumento del 2026 rende più evidente come la contribuzione nel corso degli anni e la scelta del momento di uscita incidano in modo concreto sull’importo della pensione, una realtà che diverse famiglie stanno già osservando nelle simulazioni e nei conti di fine carriera.

